Esattamente cinquecento anni fa, nel 1482, a Venezia veniva stampato per la prima volta il libro degli Elementi di Euclide. Allo scopo Erhard Ratdolt si era servito di una traduzione dall'arabo fatta circa duecento anni prima da Campano da Novara. Quando si parla del mondo classico velatamente si afferma la pretesa di una continuità greco-latina della nostra cultura. Invece dei testi originali dei maestri ellenici non c'è rimasto nulla. Aristotele o Apollonio sono conosciuti perché le loro opere furono tradotte e conservate in arabo per essere successivamente trascritte in latino nel tardo Medio Evo. Le radici dello sviluppo scientifico dell'Occidente affondano in Oriente. Fu l'espansione araba a gettare le premesse del Rinascimento. Galileo poté compiere le sue scoperte rivoluzionarie grazie al matematico persiano Al-Khwarizmi (dal cui nome deriva la parola algoritmo) che quasi otto secoli prima aveva introdotto la numerazione indiana (con lo zero e i numeri negativi), nella cultura islamica. Successivamente i nuovi numeri giunsero dagli Arabi all'Europa alla fine del Medio Evo. L'Islam insediato geograficamente tra Occidente e Estremo Oriente seppe avvicinare l'esperienza della Grecia antica con quelle indiane e addirittura cinesi. Mentre l'Europa si dibatteva tra una guerra e l'altra sorsero a Baghdad, a Fès, a Cairo, a Naishapur e altrove le prime università dove oltre a discutere di filosofia, di matematica, di medicina o di religione si realizzavano traduzioni arabe di testi greci o sanscriti. Come ha scritto Seyyed H. Nasr «ancor oggi esistono più testi aristotelici greci in arabo che in qualsiasi delle moderne lingue europee». Notevole fu il contributo alla cultura araba dei pensatori ebrei o di altre religioni. Ebreo fu ad esempio Abraham ben Ezra che, nato a Toledo nel 1092 (la Spagna era araba allora), divulgò un metodo di risoluzione delle equazioni di primo grado attribuito al matematico ebreo Job ben Salomon. Furono ebrei il filosofo Saadyah Gaon e il medico Isacco il Giudeo (vissuti ambedue tra il IX e il X secolo) che scrissero entrambi in arabo testi filosofici neoplatonici. Anche il maggior pensatore ebreo del Medio Evo, Mosè Maimoide visse e lavorò nel mondo islamico del sec. XII. Autore di una «Guida degli sviati», un tentativo di conciliazione tra Bibbia e Aristotele, egli fu medico e capo della comunità israelitica egiziana. Il problema era di risolvere la contraddizione fra il creazionismo biblico e la concezione aristotelica dell'eternità del mondo. (Un tema non completamente risolto per qualcuno nemmeno oggi, a quanto pare). Maimoide cercò di sistemare la faccenda sostenendo che non essendo nessuna delle due teorie razionalmente dimostrata, il dogma non poteva ritenersi opposto alla ragione. La lingua araba nel Medio Evo aveva un'importanza pari all'inglese di oggi. Per esempio nella Spagna musulmana, l'università di Cordova possedeva una biblioteca di 400 mila volumi catalogati in 44 libri. Non vi furono persecuzioni o intolleranze. Anche un papa, Silvestre II, che regnò tra il 999 e il 1003, studiò nella Spagna Saracena. E non a caso egli manifestò notevole interesse per le questioni scientifiche e fu autore di un trattato nel quale fece accenno ai numeri arabi, allora sconosciuti in Europa. Le persecuzioni contro gli ebrei giunsero invece con le monarchie cattoliche, che per prima cosa mandarono i libri in fumo. In Spagna oggi non sono rimasti che duemila manoscritti arabi. La storia del pensiero nel Medio Evo si accompagnò spesso alla tolleranza e a scambi a cui parteciparono uomini di diverse religioni e culture. Sarebbe davvero un peccato dimenticarlo oggi. Emanuele Azzità |
 |
 |
|
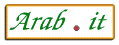 |
Copyright © A R C O SERVICE 1996-2015. All rights reserved. Tutti i diritti riservati. E-mail: info@arab.it |
