Quando l'Italia aveva le colonie, l'islamistica era molto fiorente nel nostro Paese. Poi lunghi decenni di declino. Però, dopo l'11 settembre, scuole e facoltà dove si impara la cultura araba sono prese d'assalto. Perché con quella realtà si dovranno fare i conti. Arriva un islamista da talk-show, un prodotto della postmodernità televisiva travestito da tradizionalista: in nome della laicità dello stato, principio estraneo al mondo musulmano, vuole togliere i crocifissi dalle aule scolastiche. Poi, per fortuna, c'è uno studioso del mondo islamico, Paolo Branca, che sull'inserto culturale del Sole 24 Ore spiega come, sebbene il Corano neghi la crocifissione del profeta Gesù, poeti e mistici musulmani abbiano scelto che la passione di Cristo sia simbolo delle sofferenze degli stessi popoli islamici. Quanto sappiamo davvero dell'Islam? Quanto riusciamo a vedere dietro il monolite opaco dell'integralismo o dietro i volti degli immigrati che incrociamo per strada? «Italiani, vi esorto all'islamistica» dovrebbe dire un novello Ugo Foscolo. Ma dove si trovano gli strumenti e le scuole per imparare il linguaggio di un mondo più complesso di quanto voglia farci credere la propaganda, quella xenofoba e quella integralista? L'islamistica un tempo era fiorente in Italia. Quando avevamo le colonie, quando la rivista italiana Oriente moderno era definita da Arnold Toynbee «la migliore rivista orientalistica del mondo». Poi, per lunghi decenni, nonostante alcune punte di eccellenza negli studi filologici, il declino. Dice Franco Cardini, medievista appassionato di cultura islamica, argomento che ora insegnerà all'Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli: «Eravamo la nazione con le carte più in regola, anche sul piano della geopolitica, per sviluppare gli studi sulle società islamiche. Nel 1938 l'arabo era una lingua ufficiale del nostro Paese, dato che avevamo concesso ai libici quella cittadinanza metropolitana che gli algerini aspettarono invano, fino all'ultimo, dalla Francia. Ancora oggi la grammatica dell'arabo si studia sui testi di Laura Veccia Vaglieri, semplice insegnante in una scuola per ragionieri di Bengasi. Poi abbiamo ignorato l'Islam sul piano culturale, forse per farci perdonare il passato coloniale o certe tendenze filoislamiche dei nostri politici. Come se gli israeliani, che producono alcuni tra i massimi studiosi dell'Islam, avessero mai preteso che per cortesia nei loro confronti noi abbandonassimo gli studi islamici! Il risultato è che ora in Italia la conoscenza dell'Islam è nettamente inferiore a quella dei francesi, degli anglosassoni o anche degli spagnoli». Ma l'11 settembre ha dato una sveglia e ha fatto nascere curiosità non effimere, a cui le istituzioni soprattutto accademiche cercano di rispondere. Alla Statale di Milano, la facoltà di scienze politiche ha iniziato a offrire corsi di arabo che l'anno scorso hanno raccolto cento iscritti; anche la sede universitaria della Bicocca ha appena aperto un corso analogo. La Lombardia ha varato corsi di arabo per gli studenti delle superiori: 30 ore complementari per le quali si sono già prenotati mille ragazzi. E già da tre anni all'università di Bologna è sorto il Centro interdipartimentale di scienze dell'Islam, intitolato ad Abdulaziz Ibn Saud, fondatore del regno saudita che finanzia il centro stesso, e diretto da Massimo Papa.
L'effetto Islam si vede anche in quelle che sono da sempre le sedi deputate per gli insegnamenti di arabistica e orientalistica in Italia: l'Istituto universitario orientale di Napoli, il corso di laurea in lingue orientali a Venezia e l'università La Sapienza di Roma, dove hanno fatto scuola i due maggiori esperti di mondo islamico del dopoguerra, il grande arabista Francesco Gabrieli e Alessandro Bausani, esperto del mondo persiano ma anche traduttore del Corano in italiano. «La vera novità degli ultimi tempi» puntualizza Isabella Camera d'Afflitto, allieva di Gabrieli e docente a Napoli, «è l'espandersi dell'insegnamento dell'arabo nelle facoltà, da Pavia a Lecce, da Bari a Palermo. Lo studio dell'arabo esce dal recinto dell'orientalistica. E da dieci anni, dopo il Nobel all'egiziano Nagib Mahfuz, c'è anche molto più interesse per la letteratura araba contemporanea. L'arabo non viene più solo affrontato dai filologi, bensì studiato come lingua viva. I miei studenti passano mesi a Tunisi, ad Amman o a Damasco per seguire corsi di lingua». Accanto all'antica e gloriosa tradizione accademica dell'arabistica, si è sviluppato negli ultimi anni un filone sociologico, rappresentato da studiosi come Stefano Allievi (Padova), Khaled Fouad Allam (Trieste e Urbino) e Renzo Guolo (Trieste), che ha appena pubblicato da Laterza Xenofobi e xenofili. Gli italiani e l'Islam. *****
|
 |
 |
|
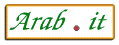 |
Copyright © A R C O SERVICE 1996-2015. All rights reserved. Tutti i diritti riservati. E-mail: info@arab.it |
