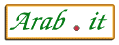|
LA SUPERPOTENZA mondiale, la nazione
che per la sua forza militare s'erge su ogni altra come accadde soltanto
all'impero romano, da chi è guidata? Quali uomini, e con quali capacità,
impongono ogni giorno le proprie scelte agli alleati e agli avversari?
Con l'11 settembre, domande del genere erano divenute sconvenienti.
I dubbi emersi nei primi mesi della presidenza Bush (per i suoi toni
ultimativi, per l'unilateralismo della visione) erano stati messi da
parte. Il mondo civile s'era sentito "americano", moralmente e politicamente
obbligato ad una totale solidarietà con l'America, deciso a non discutere
la condotta della sua leadership. E già gli alleati si preparavano,
sia pure obtorto collo, a seguire il governo degli Stati Uniti nella
"fase due" della guerra al terrorismo: l'attacco su Baghdad.
Ma da un paio di settimane è più difficile sentirsi "americani". La
catastrofe in Palestina ha infatti riportato a galla le domande sull'accortezza
dell'amministrazione Bush, consentendo a questo punto di chiedersi a
voce alta, senza più remore: chi guida la superpotenza mondiale, quali
uomini e quanto capaci? Perché quel che appare ogni giorno più evidente,
è che sono stati l'immobilismo americano degli ultimi mesi, la decisione
di non interporsi con la necessaria energia tra i contendenti, a spalancare
il baratro in cui è precipitata la Palestina.
La scelta di tenersi fuori dal ginepraio mediorientale ha avuto probabilmente
varie motivazioni. Il timore d'impantanarsi in un lungo, estenuante
andirivieni tra Ramallah e Gerusalemme, le priorità della "guerra al
terrorismo" (ancora due giorni fa il "Wall Street Journal", il giornale
più vicino all'amministrazione, la esortava a non consumare energie
in Palestina), un errore di calcolo nel sottovalutare l'effetto destabilizzante
che l'intensificarsi del conflitto avrebbe avuto sull'intera regione.
Il tutto venato da una certa insensibilità, se non si trattava di cinismo,
di fronte al cumulo dei morti in Israele e nei Territori. Quel che resta
certo, in ogni caso, è che la spirale attentati palestinesi-rappresaglie
israeliane ha ricavato dall'immobilismo americano, negli ultimi cinquanta
giorni, la sua tremenda, inarrestabile violenza. Provocando a poco a
poco la trasformazione della guerriglia in guerra aperta, facendo d'ogni
israeliano e d'ogni palestinese un omicida potenziale. Perché tutti,
in Palestina, uccidono adesso a sangue freddo. In un articolo di "Haaretz",
domenica, si chiedeva infatti ai comandi militari un maggiore controllo
sulla truppa per evitare che i soldati sparino senza alcuna vera motivazione,
mossi soltanto dal pensiero dei parenti ed amici morti negli attentati,
ad ogni arabo che compaia nel mirino del fucile.
I giudizi che vengono dal di dentro degli Stati Uniti sugli errori del
governo Bush in Medio Oriente, sono netti. "Distanziandosi in modo irragionevole
dal conflitto israelo-palestinese", diceva l'altro giorno l'editoriale
del "Washington Post", "la Casa Bianca ha concretamente contribuito
a spingere la situazione al suo punto di non ritorno". E in effetti,
tra dicembre e la metà di marzo l'inerzia è stata impressionante. In
Palestina i morti aumentavano a dismisura, ma George Bush si limitava
a ripetere più o meno tali e quali le parole di Sharon: Arafat metta
fine agli attentati, e poi si vedrà. La situazione precipitava, europei
e arabi invocavano l'intervento degli Stati Uniti, ma Bush non vedeva
alcuna necessità d'inviare nella zona un mediatore: neppure lo scolorito
e impacciato generale Zinni, che in dicembre aveva fatto una rapida
ricognizione della catastrofe e poi, alle prime difficoltà, era rientrato
in patria.
A quanto pare, nell'amministrazione s'erano levate varie voci a chiedere
un intervento più fermo nei confronti dell'ampiezza e rovinosità delle
rappresaglie israeliane. In parecchi s'erano convinti che l'ondata spaventevole
dei kamikaze non poteva essere neutralizzata con sempre più massicce
campagne militari. Altri proponevano (come adesso stanno chiedendo i
democratici al Congresso) l'invio nella zona del segretario di Stato
Colin Powell. Altri ancora facevano notare che Sharon aveva fatto passi
gravi come il confinamento di Arafat e la rioccupazione di grossi pezzi
dei territori dell'Autorità palestinese, così come nel giugno dell'82
aveva avviato l'invasione del Libano: senza sapere esattamente, cioè,
con quali obbiettivi finali e a quale costo. Tant'è vero che mentre
nel corso della prima "Intifada" era morto un solo israeliano ogni venticinque
palestinesi, adesso la proporzione è di uno a tre.
Ma Bush non si muoveva. E non s'è mosso sino alla metà di marzo, quando
distogliere lo sguardo dal sangue che scorreva in Palestina era ormai
divenuto impossibile. Ancora adesso, tuttavia, quante ambiguità e ondeggiamenti.
Il 13 marzo gli Stati Uniti votano al Consiglio di sicurezza dell'Onu
per la nascita d'uno Stato palestinese, e Bush dichiara che la politica
di Sharon "non favorisce" la ricerca d'una soluzione. Ma nei giorni
successivi l'accento è di nuovo posto sulle colpe di Arafat. Sabato
scorso c'è un'altra risoluzione del Consiglio di sicurezza, anch'essa
votata dall'America, con cui si chiede l'arresto degli attentati palestinesi
e allo stesso tempo il ritiro dell'esercito israeliano. Sembra un passo
decisivo, una svolta della politica di Washington. Ma poche ore dopo
ecco il passo indietro: il presidente parla, e parla per giustificare
l'offensiva militare di Sharon come "diritto all'autodifesa".
Il risultato di questo misto d'immobilismo e sortite contraddittorie,
è che ogni possibilità di fermare la guerra in Palestina appare oggi
puramente teorica. Le possibilità reali si sono consumate negli ultimi
due mesi, salvo (forse) una: l'intervento d'una forza armata tutta americana
- e quindi accettabile, almeno virtualmente, anche da parte israeliana
- col compito di separare i belligeranti. Ma d'una simile iniziativa
non s'intravvede a Washington il minimo accenno, e infatti Sharon ignora
la risoluzione dell'Onu e fa avanzare l'esercito nelle strade delle
città palestinesi.
Così, le domande di cui si diceva all'inizio divengono sempre più inquietanti:
chi guida la superpotenza mondiale, quali uomini e quanto capaci? Alcune
cose, certo, le conoscevamo già: gli atteggiamenti di superbia o noncuranza
nei confronti degli alleati, l'ostentazione d'una forza militare senza
rivali, l'assenza di qualsiasi tentativo per rendere più accettabile
agli "altri",amici o potenziali avversari, la propria preponderanza.
Ma adesso sappiamo anche che sono stati i loro errori ad aggravare la
catastrofe in Palestina, errori che allarmano perché inducono a dubitare
fortemente dell'avvedutezza politica di chi li ha commessi. Come si
può continuare allora, qualsiasi cosa accada, a sentirsi "americani"?
*
Commento di Sandro
Viola pubblicato su La Repubblica del 02.04.2002.
|